L'UMANESIMO
 L'Umanesimo si sviluppa nel Quattrocento dove si propone il ritorno al mondo classico, per ridare vita a una cultura che collocava al centro dei propri interessi l'uomo, la sua dignità e libertà. Si tratta di un progetto che prosegue nel Cinquecento e si diffondo in Europa, venendo ad assumere il nome di Rinascimento. Umanesimo e Rinascimento sono i due grandi eventi che affermano la centralità dell'uomo nel cosmo; una centralità che in qualche modo va a sostituire il ruolo che nel Medioevo era occupato da Dio. I pensatori di quest'epoca, ritengono che Dio, creando l'uomo, gli abbia affidato anche il dominio sulla Terra e su tutte le altre creature. Per fare questo però è necessario che egli si impadronisca dei segreti della natura attraverso lo studio dei suoi principi.
L'Umanesimo si sviluppa nel Quattrocento dove si propone il ritorno al mondo classico, per ridare vita a una cultura che collocava al centro dei propri interessi l'uomo, la sua dignità e libertà. Si tratta di un progetto che prosegue nel Cinquecento e si diffondo in Europa, venendo ad assumere il nome di Rinascimento. Umanesimo e Rinascimento sono i due grandi eventi che affermano la centralità dell'uomo nel cosmo; una centralità che in qualche modo va a sostituire il ruolo che nel Medioevo era occupato da Dio. I pensatori di quest'epoca, ritengono che Dio, creando l'uomo, gli abbia affidato anche il dominio sulla Terra e su tutte le altre creature. Per fare questo però è necessario che egli si impadronisca dei segreti della natura attraverso lo studio dei suoi principi.L'umanesimo è l'espressione con cui si vuole designare la cultura del 400 e ha il suo fulcro geografico nelle città itarliane, in particolare Firenze. In questa città sorge l'Accademia platonica.
Il termine Umanesimo allude a due concetti intrecciati tra loro: in primo luogo designa la centralità che viene ad assumere in questo periodo la riflessione sull'uomo; in secondo luogo indica il nuovo indirizzo degli studi, che ora si orienta verso le humanae litterae, cioè uno studio attento e accurato anche dal punto di vista linguistico, delle opere degli autori classici.
L'umanista Poggio Bracciolini ha l'occasione di cercare e reperire nelle biblioteche dei monasteri le opere di autori come Quontiliano, Vitruvio, Lucrezio, Stazio e Cicereone.
Gli umanisti mirano a ripristinare il testo nella sua forma originale, attraverso il confronto delle diverse redazioni esistenti e l'intelligente interpretazione del pensiero degli autori antichi. L'umanista Lorenzo Valla dimostra la non autenticità di un importante documento, la cosiddetta Donazione di Costantino, l'atto con cui l'imperatore Costantino avrebbe concesso a papa Silvestro la giurisdizione su Roma, l'Italia e l'intero Impero romano d'Occidente.
E' proprio con l'Umanesimo che la filologia diventa una scienza vera e propria, accurata e precisa e si diffonde in Europa con la conoscenza delle lingue greca e latina. Anzi, il latino diventa la lingua ufficiale della nuova Europa.
La diffusione del latino come lingua della comunicazione filosofica e letteraria deve essere apprezzata in quanto viene a costruire un mezzo per la circolazione delle nuove idee umanistiche e scientifiche tra i dotti europei, che ora possono leggere e conoscere le opere che si pubblicano in ogni parte del vecchio continente. Tale risultato è reso possibile anche grazie alla stampa a caratteri mobili. La lingua latina cederà poi il passo alle lingue volgari.
IL RINASCIMENTO
Il termine ''Rinascimento'', che risale al Cinquecento, indica quel complesso periodo in cui si assiste a un profondo rinnovamento in tutti i campi, da quello artistico a quello religioso, da quello filosofico a quello scientifico. Si tratta di una fase in cui si manifesta una negativa considerazione per il Medioevo.
Gli intellettuali dell'epoca dicono che lo studio rigoroso dei testi classici è concepito come una funzionale a un reale progresso pratico degli uomini.
Nel concetto Rinascimento emerge l'idea secondo cui la cultura classica si offre come stile di vita e si diffonde oltre le mura delle accademie per raggiungere la società civile.
Leonardo da Vinci progettò un canale per dare alla città un accesso navigabile al mare. Tra i suoi disegni si annoverano schizzi di razzi, missili, palle di cannone. Leonardo mostra interesse costante per il perfezionamento degli strumenti in grado di far risparmiare fatica all'uomo e migliorare le condizioni della vita civile e militare. Il Rinascimento si espande anche nel resto di Europa, come in Francia, nei Paesi Bassi, in Germania. Proprio in Germania si sviluppa la Riforma protestante.
Il principio di questa riforma era il libero esame delle Scritture, affermato da Martin Lutero. Questo principio sosteneva che ogni fedele si doveva rapportare direttamente al testo sacro mettendo in crisi il ruolo del magistero ecclesiastico, recuperando la dimensione dell'interiorità della fede contro il ritualismo della Chiesa romana che si era mondanizzata tanto da fare commercio delle verità religiose e vendere ai fedeli le indulgenze. Il ruolo della Chiesa viene messo in discussione da Lutero, il quale nega il suo valore di mediatrice tra l'uomo e Dio. come ogni credente è in grado di cogliere la verità contenuta nelle Scritture direttamente così non è la Chiesa a dispensare la grazia di cui l'uomo ha bisogno di salvarsi, in quanto solo Dio detiene tale potere. Solo la fede può portare gli uomini alla salvezza. Nasce anche una nuova attenzione per la natura.
Con l'Umanesimo si verifica una vera e propria riscoperta di Platone. Nella disputa tra platonici e aristotelici si evidenzia la contrapposizione tra due diversi orientamenti culturali: se i platonici sono interessati a una rinascita spirituale e religiosa e vedono nel platonismo l'espressione più alta della religiosità antica, gli aristotelici trovano nei testi di Aristotele uno stimolo per l'approfondimento della ricerca razionale e naturalistica. I centri geografici di queste correnti sono a Firenze per il platonismo e per l'aristotelismo a Padova.
L'ACCADEMIA PLATONICA DI FIRENZE
I motivi che favoriscono la diffusione della filosofia nelle diverse città è il rifiorire dell'economia e della vita civile dopo la crisi demografica del Trecento. Gli intellettuali abbracciano un ideale di vita derivante dai classici, che contempla l'eccellenza del sapere con le esigenze della vita pratica.Questo vale ad esempio nell'Accademia platonica di Marsilio Ficino. Secondo lui esiste un'unica tradizione filosofico- religiosa, che annovera tra i suoi rappresentanti figure di poeti come Omero o Virgilio. Essa rappresenta il progressivo rivelarsi dell'unica verità divina. Ficino cerca di rafforzare l'accordo tra platonismo e cristianesimo.
Il tema dell'opera di Giovanni Pico della Mirandola, hominis dignitate è la centralità dell'uomo e la superiorità rispetto alle altre creature. Per Pico l'uomo è un essere intermedio e può influire sulla sua stessa natura.
A Padova si approfondisce la tradizione del pensiero aristotelico. Le varie correnti di aristotelici sono accomunate da una mentalità razionalistica e naturalistica.
Il più importante tra gli aristotelici è Pietro Pomponazzi che accentua i motivi del naturalismo arrivando ad affermare che la vera essenza dell'uomo è quella corruttibile e corporea. Secondo lui l'intelletto umano non opera indipendentemente dai sensi e l'anima non può essere considerata immortale.
Le due correnti sono l'espressione del bisogno rinascimentale di libertà intellettuale e di indipendenza dalla tradizione scolastica e medievale.
La seconda modernità comprende l'idealismo tedesco, da Fichte a Hegel. Nel complesso fenomeno della modernità i seguenti nuclei tematici sono:
- L'Umanesimo e il Rinascimento dei secoli XV- XVI, periodi che costituiscono il momento aurorale della modernità
- la rivoluzione scientifica e la nuova immagine dell'uomo e della natura, che si configurano come il ''fatto'' centrale dei secoli XVI e XVII
- L'illuminismo e la fede nel progresso civile e morale dell'umanità, che rappresentano la riflessione propria del Settecento
- L'idealismo tedesco, visto come estrema fase della modernità perché si caratterizza, soprattutto in Hegel, come una delle ultime grandi narrazioni che esaltano la fede nella ragione, nello spirito, nel progresso e nell'inevitabile esito di civilizzazione della storia.
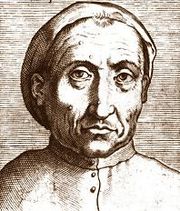



Nessun commento:
Posta un commento